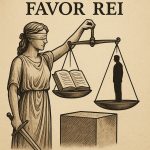-
Premessa: le sanzioni antiriciclaggio in generale
Le violazioni al cd. decreto antiriciclaggio sono presidiate da un duplice ordine di sanzioni, le quali possono assumere natura penale ed amministrativa.
Alle disposizioni sanzionatorie è dedicato l’intero titolo V del D.Lgs 231/2007, il quale, a sua volta, risulta suddiviso in due Capi.
All’interno del Capo I si individua l’art. 55, rubricato espressamente “fattispecie incriminatrici”. Si tratta di una norma a più fattispecie che individua diverse ipotesi, tutte connotate da un’elevata decettività. Coerentemente alla loro maggiore offensività, il legislatore accorda alle fattispecie in esame un’esplicita rilevanza penale. Ci proponiamo di dedicare un apposito contributo a tale disposizione, per procedere ad un’analisi dettagliata della stessa.
Al contempo, il Capo II contempla svariate ipotesi di sanzioni amministrative, agli artt. 56 ss.
Il contributo si propone di indagare la concreta natura delle sanzioni da ultimo menzionate. A tal fine, si procederà mediante l’ausilio di principi CEDU e costituzionali.
-
Introduzione alle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali
A parere di chi scrive sembra indispensabile operare una premessa. Indagare la natura di sanzioni esplicitamente definite dalla norma come “amministrative” parrebbe impresa esegetica confinante con la follia.
Lo scopo dell’analisi non è quello di sottrarre tempo al lettore, né tantomeno quello di fornire una mera disamina di canoni interpretativi fini solamente a sé stessi.
Al contrario, l’indagine si giustifica in virtù del corso interpretativo vigente in tema di sanzioni, a far data dalla celebre sentenza Engel del 1976 della Corte EDU. Nel celebre arresto, i giudici alsaziani approdano ad un vero e proprio mutamento di paradigma, giungendo a fondare il c.d modello sostanziale.
Si allude all’affermazione del principio di indifferenza degli schemi nominali e formali utilizzati dagli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 1950, con specifico riguardo all’ambito sanzionatorio. In altri termini, la Corte sovrannazionale giunge ad elaborare un’autonoma nozione di “pena” e di “sanzione penale”, diversa da quella accolta dagli ordinamenti interni e non fondata sulla mera qualificazione “giuridico formale”. Da tale asserzione teorica consegue che una sanzione, dichiarata “amministrativa” da parte di uno Stato aderente alla Convenzione, potrebbe essere ritenuta una vera e propria pena dalla Corte, al ricorrere di determinati indici.
Si precisa che tale affermazione vale soltanto con riguardo a sanzioni non formalmente definite come penali. Al ricorrere della qualificazione di un illecito alla stregua di una “pena”, non si pone affatto la necessità di applicare le garanzie che l’ordinamento predispone in materia. In tal caso, le guarentigie proprie della disciplina penale si intendono automaticamente estese al soggetto agente.
Diverso è il caso in cui si proceda all’applicazione di sanzioni formalmente amministrative, ancorché molto severe od incisive. In tal caso, il destinatario di tali conseguenze sanzionatorie “ipermuscolari” potrebbe risultare pregiudicato dalle scarne tutele apprestate dal diritto amministrativo. Di qui, si possono agilmente scorgere le ragioni del corso interpretativo vagliato dalla Corte EDU, la cui finalità è prettamente garantista.
Lo scopo perseguito dai magistrati di Strasburgo è quello di pervenire all’applicazione delle garanzie penali anche a seguito dell’irrogazione di una sanzione amministrativa, purché essa risulti connotata da alcuni caratteri.
-
Gli indici di una sanzione sostanzialmente penale: i criteri Engel
I criteri alla luce dei quali le misure punitive devono essere qualificate come penali sono stati enucleati nella menzionata sentenza Engel c. Paesi Bassi del 1976 e poi ribaditi in altri celebri casi: si tratta delle sentenze Öztürk c. Germania del 1984 e Grande Stevens e altri c. Italia del 2014.
In particolare, con l’ultimo degli arresti menzionati la Corte EDU ha sancito la natura di pene delle sanzioni Consob in materia di abusi e manipolazione del mercato, di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del TUF.
Inscritti nel solco dell’approccio pragmatico e sostanzialistico di cui sopra, i c.d. criteri Engel (o Engel criteria) sono:
1) la qualificazione giuridico-formale dell’infrazione nel diritto interno (o dell’Unione) (c.d. criterio formale);
2) la natura dell’infrazione e degli interessi presidiati (c.d. primo criterio sostanziale);
3) il carattere o il grado di severità della sanzione, ossia l’afflittività della stessa (c.d. secondo criterio sostanziale).
Si tratta di criteri tra di loro alternativi e non cumulativi, dal momento che risultano ispirati a diverse giustificazioni strutturali.
Al ricorrere del primo criterio e dell’irrogazione di una pena, la Corte EDU si asterrà da qualunque scrutinio ulteriore sul punto. Mentre è al ricorrere delle ipotesi previste dal secondo e tal terzo criterio che la Corte potrà qualificare come penali sanzioni che, negli ordinamenti interni, assumono una forma amministrativa.
Illustrati i criteri Engel, possiamo ora calare in tale contesto le sanzioni disciplinate dagli artt. 56 ss. del D.Lgs. 231/2007. Si tratta di un corredo di sanzioni eterogenee e distinte tra loro, che, tuttavia, per evidenti ragioni, non sarà possibile attenzionare singolarmente.
Da un lato, preme sottolineare la quasi totale mancanza di contributi dottrinali volti a sondare la natura del corredo sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231. Dall’altro, la scarsezza di giurisprudenza relativa alla natura delle sanzioni di cui al codice antiriciclaggio rende difficoltoso orientarsi agevolmente in materia.
Alla luce di ciò, si proverà a rendere conto e ragione di alcuni orientamenti che potrebbero contendersi il campo.
-
La tesi della natura amministrativa natura delle sanzioni antiriciclaggio
Secondo una prima ricostruzione, quelle di cui al decreto antiriciclaggio potrebbero essere inscritte nel novero delle sanzioni puramente amministrativa. A sostegno di tale assunto potrebbero porsi due principali apparati argomentativi.
In primo luogo, potrebbe invocarsi il supporto del criterio letterale. Nell’enfatizzare la lettera del decreto, che allude alla previsione di “sanzioni amministrative”, si potrebbe concludere nel senso dell’esclusione di un rilievo penale degli illeciti in commento. Tale impostazione risulterebbe avvalorata dalla presenza di incisi quali “salvo che il fatto costituisca reato” nel corpo di alcune disposizioni, come all’artt. 58, commi 1 e 2. La presenza di clausole siffatte potrebbe indurre a ritenere esclusa la natura penale delle previsioni in commento.
In secondo luogo, potrebbero richiamarsi taluni principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte in ambito sanzionatorio. Si allude in particolare a quanto stabilito da Cass. Civ. sez. II, 26/09/2019, n.24081, secondo cui “…Nell’ordinamento del credito e della finanza… una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di Euro 5.000 ed il massimo edittale di Euro 500.000… non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale”. Da un’analisi congiunta delle sanzioni di cui al decreto antiriciclaggio, sembrerebbe potersi osservare che il numero delle sanzioni pecuniarie superiori al massimale suindicato risulti del tutto minoritario.
Tuttavia, a parere di chi scrive, le argomentazioni appena illustrate si prestano a molteplici critiche e presentano fallacie di non poco momento. In primo luogo, come già osservato, la mera qualificazione formale di una sanzione come amministrativa non esime l’interprete da un’indagine sostanziale sulla natura della stessa, alla luce dei criteri Engel. Inoltre, l’applicazione di un mero calcolo aritmetico per sondare la natura di una sanzione pare non bastevole, necessitando l’impiego di un’analisi più approfondita ed attenta.
-
La tesi della natura sostanzialmente penale delle sanzioni antiriciclaggio
Sul versante opposto, è possibile individuare una linea interpretativa che conclude nel senso della natura sostanzialmente penale delle sanzioni in esame. Militano il tal senso una pluralità di argomenti.
5.1 Prima argomentazione: gli interessi presidiati dal D.lgs. 231/2007
In primo luogo, pare difficilmente confutabile la circostanza secondo cui le sanzioni di cui al decreto antiriciclaggio presidino interessi generali e valori particolarmente rilevanti per l’ordinamento. Espliciti in tal senso risultano i commi 1 e 2 dell’art. 2 del decreto. Infatti, gli illeciti ivi previsti mirano a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, sono volte a proteggere il mercato ed il sistema finanziario nel suo complesso. In tal senso poggiano anche gli ultimi approdi a cui è giunta la Suprema Corte con riguardo alla natura dell’art. 648 bis c.p. In particolare, secondo i Giudici il reato di riciclaggio deve ritenersi plurioffensivo, poiché volto a presidiare, oltre al patrimonio, beni giuridici come l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico e l’ordine economico-finanziario.
In secondo luogo, possono individuarsi cospicue sanzioni prive di qualsivoglia finalità risarcitoria, elaborate secondo una logica puramente deterrente e repressiva. Infatti, da un esame della casistica emerge come, al ricorrere di conseguenze meramente afflittive, si possa concludere per la natura penale della sanzione. Al contrario, misure volte a ripristinare lo status quo ante o a riparare lesioni patrimoniali potrebbero considerarsi indici altamente probabili di esclusione del carattere di pena.
5.2 Seconda argomentazione: lo “stigma sociale”
In aggiunta, è possibile riscontrare sanzioni dotate di un elevato grado di afflittività, alla luce della misura dell’importo pecuniario edittale. Si pensi alla previsione di cui all’art. 4 lett. b dell’art. 58, in tema di violazioni gravi, ripetute o sistematiche produttive di un vantaggio economico per i soggetti obbligati vigilati. A tal fine, la norma prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino ad 1.000.000 di euro per vantaggi indeterminabili. Si allude anche all’ipotesi di cui all’art. 62 comma 1, in analogo contesto ma con riferimento agli intermediari bancari e finanziari. La disposizione contempla la possibilità di applicare sanzioni fino a 5.000.000 di euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale sia superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato sia determinabile.
Per di più, la normativa prevede ipotesi di particolarmente severe in tema di misure interdittive. Si allude all’ipotesi di cui 62 comma 3, secondo cui le Autorità di vigilanza del settore possono disporre l’applicazione della misura di interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. Ciò con riguardo alle ipotesi di cui al comma 2 della norma in commento. Un simile effetto è previsto anche ai sensi dell’art. 64 comma 4 con riferimento a determinate violazioni gravi perpetrate dai distributori od esercenti nel comparto del gioco. In aggiunta, può menzionarsi il meccanismo di cancellazione dagli elenchi di cui agli artt. 112-bis e 128-undecies TUB, ordinato al ricorrere di violazioni gravi, previsto dall’art. 65 comma 7. Infine, si richiama il disposto di cui all’art. 66 comma 1, che, al ricorrere di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, contempla l’irrogazione automatica dell’interdizione dalla funzione fino a 5 anni. Ciò, unitamente alla pubblicazione con modalità telematiche del relativo decreto di condanna per un analogo periodo.
In tal senso, la Corte EDU, nel valutare la possibile rilevanza penale di una sanzione, valorizza l’impatto sociale e personale sulla persona conseguente all’irrogazione della stessa. In particolare, è opportuno valutare le conseguenze sanzionatorie sulla base del criterio del c.d. stigma sociale che deriva dalla pubblicità, dalla gravità morale e dall’effetto di esclusione pubblica della sanzione. Alla luce di quanto osservato, sembra che le misure di cui sopra possano essere qualificate come altamente impattanti sulla dimensione umana, sociale e professionale del soggetto sanzionato.
5.3 Terza argomentazione: la presenza del principio del favor rei nella normativa AML
Infine, un indice di cui tenere conto nell’analisi in esame è l’introduzione del principio del favor rei nella disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007, di cui abbiamo dato conto nel contributo di cui al link. Nella sua versione attuale, l’art. 69 comma 1 richiama un presidio tipico del diritto penale e sostanzialmente estraneo al sistema delle sanzioni amministrative. Tale rilievo risulta significativo nell’avvalorare la natura sostanzialmente penale del sistema sanzionatorio di cui al decreto.
-
La tesi mediana
Tutto ciò premesso, appare preferibile sostenere una tesi mediana tra le due ora proposte. Da un lato, concludere nel senso della natura puramente ammnistrativa delle sanzioni di cui al decreto AML sembra insoddisfacente e contrario al principio di effettività della tutela. Dall’altro, parrebbe eccessivo ritenere che tutte le ipotesi previste dal decreto debbano essere inscritte nel novero delle sanzioni penali. Così, le ipotesi di cui agli artt. 58 e 62 potrebbero contenere indici sufficienti, al fine di qualificarle come “pene camuffate”. Mentre altre fattispecie sanzionatorie non conterrebbero parametri di sicura rilevanza, al fine di sondarne un’eventuale natura penale.
Si ritiene necessario valutare ogni fattispecie come ipotesi a sé stante, alla luce dei criteri Engel già indicati.
-
Le conseguenze della natura sostanzialmente penale di una sanzione
La natura sostanzialmente penale di una sanzione comporta l’applicazione non solo delle garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ma anche delle garanzie costituzionali interne. Superate le argomentazioni offerte nella sentenza n. 43 del 2017 ed il relativo sistema dualistico, la Corte costituzionale ha infatti affermato l’adesione alla tesi del c.d. modello monistico con la sentenza 68 del 2021.
In particolare, il Giudice delle leggi ha affermato che una sanzione siffatta debba godere delle medesme guarentigie previste per le sanzioni penali nell’ordinamento nazionale. Da ciò discende la necessità di applicare, da un lato, i principi di legalità, giusto processo e altre tutele previste dagli artt. 6 e 7 CEDU. Dall’altro, quella di assicurare la tutela offerta dai principi costituzionali italiani, come il canone di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il principio di legalità penale ed i suoi corollari di cui all’art. 25 e tutti gli altri cardini propri del sistema penale.
-
Conclusioni sulla lettura da offrire al sistema delle sanzioni antiriciclaggio
Il contributo ha messo in luce alcuni indici potenzialmente idonei a consentire l’ingresso di alcune sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2007 nel novero delle “pene camuffate”, elaborate dalla CEDU. Laddove tali argomentazioni dovessero essere condivise nelle aule di giustizia, le conseguenze di sistema sarebbero dirompenti. Infatti, pare evidente come l’eventuale applicazione delle garanzie penali, conseguente all’irrogazione di sanzioni AML, potrebbe offrire maggiore tutela agli operatori del settore.
Nell’impossibilità di prevedere gli arresti giurisprudenziali sul punto, sembra opportuno suggerire comportamenti di cautela.
In conclusione, come appena dimostrato, non c’è dubbio che un approccio consulenziale in materia meramente ricognitivo della normativa interna risulterebbe vano, stante l’importanza della prospettiva multilivello e della padronanza del diritto eurounitario.